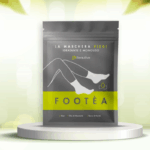Il motivo per cui alcuni strumenti musicali sono chiamati “legni” anche se oggi sono costruiti in metallo risiede principalmente nella loro origine storica e nel metodo di produzione del suono. Originariamente, questi strumenti erano realizzati in legno, da cui deriva la loro denominazione tradizionale, che è rimasta invariata anche con il cambiamento dei materiali impiegati nella costruzione. La classificazione non dipende quindi dal materiale attuale ma dal funzionamento acustico e dalla tipologia di imboccatura utilizzati per produrre il suono, peculiarità che li distingue dalla famiglia degli “ottoni” e dagli altri strumenti a fiato.
L’evoluzione della famiglia dei legni
Nel passato, gli strumenti come il flauto traverso, il clarinetto, l’oboe e il fagotto venivano quasi sempre costruiti in legno, ma esistevano anche versioni realizzate con osso o avorio. Questi strumenti caratterizzavano la famiglia dei “legni” per la loro particolare produzione del suono, generato tramite imboccatura con ancia (semplice o doppia) oppure tramite un foro d’imboccatura. Nel corso dei secoli, grazie agli avanzamenti tecnologici e alla ricerca di maggiore robustezza, facilità di manutenzione e resa sonora, si è iniziato a realizzare strumenti anche in metallo o materiali sintetici.
Nonostante la variazione dei materiali, il termine “legni” è rimasto, poiché la modalità con cui il suono viene prodotto non è cambiata. Quest’ultima si differenzia nettamente da quella degli “ottoni”, in cui il suono deriva dalla vibrazione delle labbra del musicista contro il bocchino, mentre nei legni la colonna d’aria viene modulata tramite l’apertura di fori gestiti dalle dita o dalle chiavi.
Metodo di classificazione e differenze con gli ottoni
La classificazione tra “legni” e “ottoni” non è legata unicamente alla composizione del materiale, bensì al sistema di produzione del suono. Le principali differenze includono:
Le funzioni melodiche e la capacità di produrre timbri caldi e variabili rendono i legni strumenti solisti e fondamentali nell’orchestra e nella musica da camera
(per approfondire la classificazione degli strumenti legni).
Ulteriori approfondimenti sui materiali
L’introduzione dei materiali metallici risponde a diverse esigenze moderne: il metallo offre maggiore resistenza, durata e stabilità rispetto al legno, soprattutto nei cambiamenti climatici e nell’usura. Tuttavia, il caratteristico timbro degli strumenti legni rimane riconoscibile in virtù della forma interiore, dell’imboccatura e del sistema dei fori o delle chiavi. In qualche caso, la costruzione in legno è mantenuta per strumenti specifici, come il flauto dolce, per preservare la ricchezza e la profondità del suono originario.
La presenza di materiali “non legnosi” ha portato anche allo sviluppo di strumenti in materiali plastici e compositi, utilizzati soprattutto nell’ambito didattico e per la pratica musicale in condizioni particolari. Nonostante questa trasformazione, i parametri di classificazione orchestrale rimangono quelli definiti dalla tradizione, dimostrando l’importanza della storia costruttiva e musicale nella denominazione degli strumenti.
La famiglia dei legni nell’orchestra
Il ruolo dei legni nell’orchestra è fondamentale e va ben oltre la semplice distinzione materiale. Essi vengono apprezzati per la loro versatilità, per la varietà timbrica e per la capacità di dialogare efficacemente con gli altri strumenti, siano essi archi, ottoni o percussioni. Ecco i principali appartenenti alla famiglia dei legni:
In orchestra, il gruppo dei legni rappresenta la sezione capace di colorare le melodie grazie alla perfetta fusione tra tecnica costruttiva di derivazione storica e innovazioni contemporanee nei materiali (per maggiore approfondimento sulle caratteristiche dei strumenti legni).
Conclusione: la tradizione che resiste nel tempo
L’appellativo “legni” attribuito a strumenti formati anche da metallo o plastica è il risultato di una tradizione musicale molto antica che ha scelto di conservare la terminologia storica per ragioni di chiarezza, funzionalità e universalità nella didattica e nell’orchestrazione. Questo esempio dimostra come, nella musica, la storia e la prassi siano talvolta più solidi della materia stessa, consentendo continuità fra passato e presente e collegando strumenti di epoche e materiali differenti attraverso le stesse tecniche e lo stesso nome.